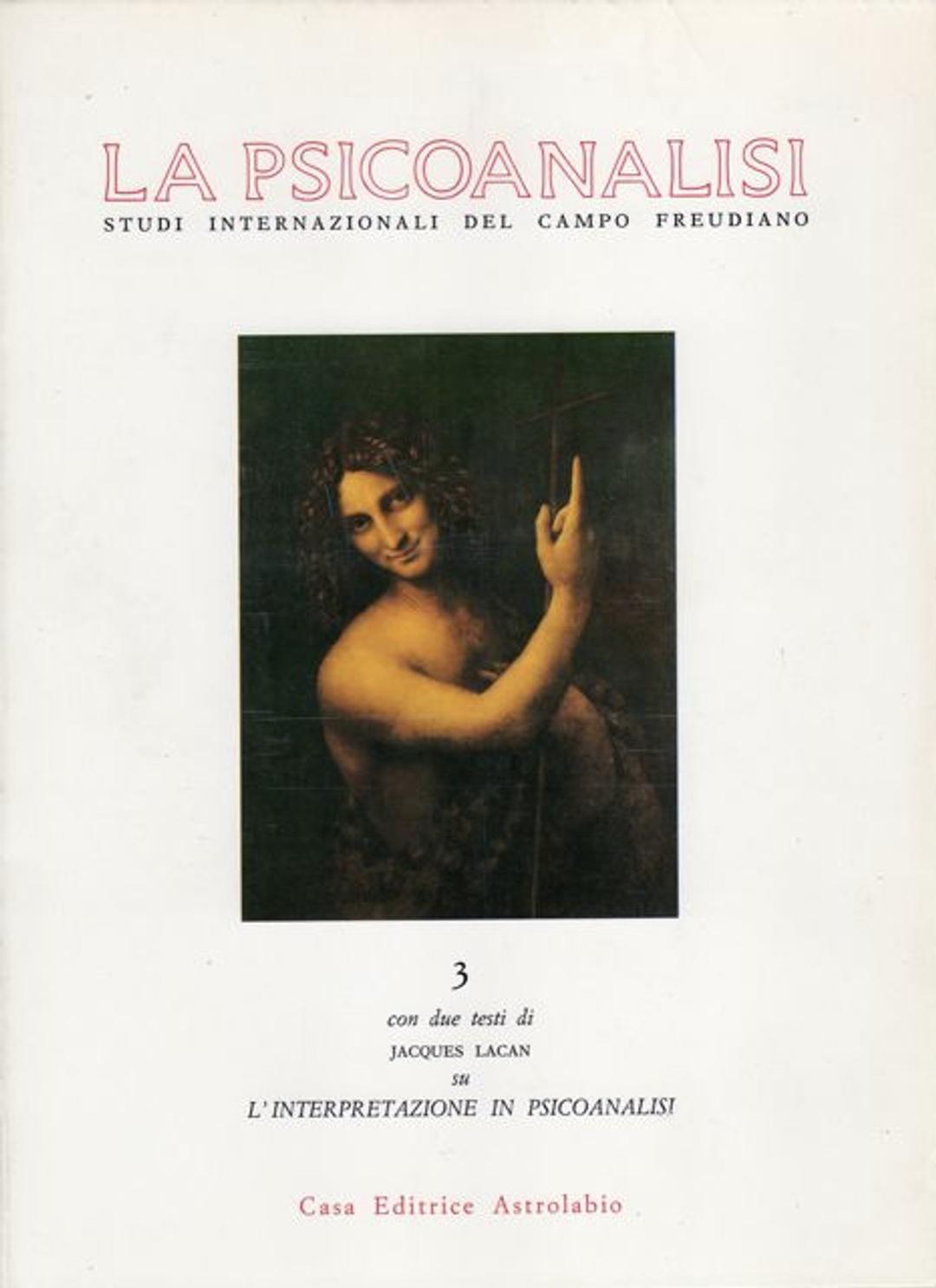Il procedimento inventato da Freud può essere riassunto in due termini: l’associazione libera, che definisce il compito dell’analizzante, e l’interpretazione, cioè la risposta dell’analista. Ma questi due termini non definiscono totalmente il legame analitico e l’incidenza dell’analista non si riduce neanche solo all’interpretazione, poiché esiste l’amore di transfert che Freud scopre con sorpresa, nel quale la presenza dell’analista interviene come supporto della funzione, non dell’interprete, ma dell’oggetto.
Non sempre gli analisti post freudiani hanno saputo distinguere e articolare questi due registri dell’esperienza. A volte l’interpretazione è stata considerata, come da Glover, l’elemento centrale dell’impatto dello psicoanalista; oppure la sua importanza è stata minimizzata, come da Balint, fino al punto di escluderla dall’esperienza.
Non si può dire che Freud non abbia mostrato in parecchie maniere, soprattutto nei casi clinici, il modo in cui interveniva, ma in realtà, malgrado questi esempi, Freud non ha mai definito l’interpretazione analitica, anche perche gli manca un termine per situare ciò che nell’azione analitica non è solo interpretazione. Perciò nel 1967 Lacan introdurrà il termine di ‘atto’.
Freud prende in prestito il vocabolo di interpretazione dall’oracolo e dalla psicosi. La psicoanalisi deve perciò definire (se vuole mantenere la sua correlazione alla scienza) cosa determina il suo uso e cosa la distingue dai vaticini ermeneutici folli o ispirati.
Apofantica, rivelatrice, l’interpretazione analitica è tuttavia sottomessa alla struttura in cui prende posto. Quest’ultima decide delle condizioni del suo impatto e fissa dunque i suoi limiti, anche se non basta a dettarle i suoi compiti, se non appare quell’elemento insostituibile che Lacan ha chiamato “desiderio dello psicoanalista”, indispensabile per supplire alla mancanza di ciò che sarebbe una “massima universale” dell’interpretazione.
L’interpretazione è dunque in mano all’analista, per non dire alla sua arte, visto che non la si impara come un sapere e che anche la sua esemplificazione viene fatta con grande sforzo, per l’“aporia” del suo resoconto, come dice Lacan.
Non esiste la possibilità di una legislazione dell’interpretazione.
Ciò non significa che non la si possa situare nei matemi della struttura. Nel costruirla come funzione della parola di cui l’analisi si serve, del linguaggio che essa suppone e del discorso che la ordina, Lacan, nel corso del suo insegnamento, ha creato le sue formule successive.
Senza dubbio l’interpretazione può essere usata al plurale, in parecchi modi (non fosse altro, ad esempio, nella distinzione tra l’operazione che produce la significazione e quella che isola un significante principale) poiché le sue attualizzazioni possono essere svariate a seconda del suo posto nella struttura a un dato momento della cura. Ma poniamo la sua finalità al singolare: in fin dei conti l’interpretazione cerca la verità? Sì, senza dubbio, ma a condizione di aggiungere che la verità stessa nasconde e rivela allo stesso tempo il suo referente. Nelle sue chiacchiere essa suppone... il reale, o piuttosto ciò che “fa funzione” di reale in questa esperienza di sapere che è l’inconscio in esercizio nel transfert. Questo è il vero bersaglio.
___
Poiché la versione cartacea di questo numero è esaurita, mettiamo a disposizione il PDF de La Psicoanalisi n.3 nel link del SOMMARIO dell'articolo. Per accedervi, è necessario effettuare la connessione e versare la quota come membro aderente dell'Atelier Tyto Alba ASBL..