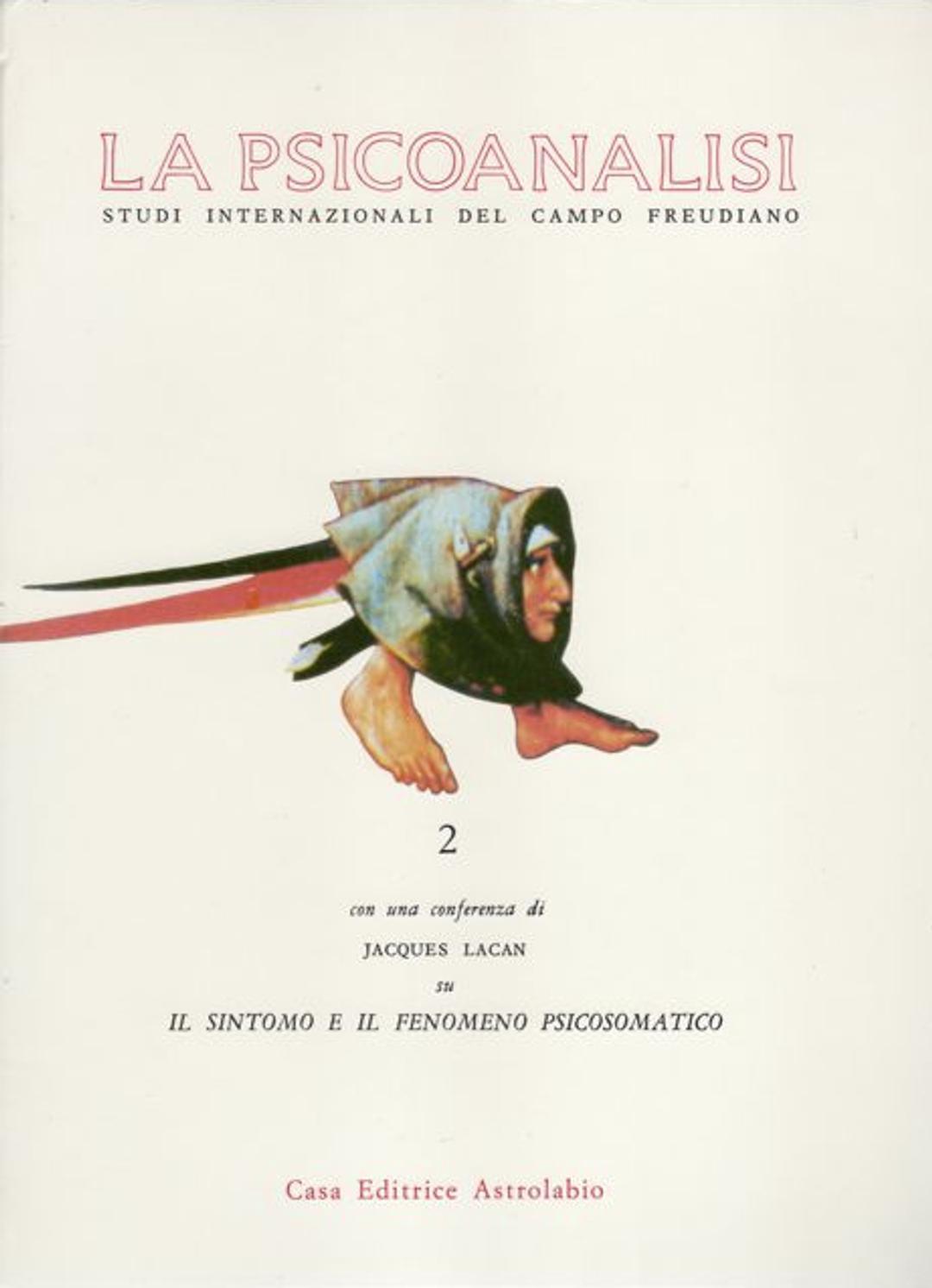Lacan non ha mai trattato in modo specifico dei fenomeni psicosomatici. Propone però preziose indicazioni nel Seminario II, nel Seminario XI e nella conferenza sul sintomo riportata in questo numero, in cui afferma che si tratta di un campo ancora inesplorato.
Nella mia formazione medica e scientifica sono stato colpito dall’insistenza di Lacan a sottolineare nel suo insegnamento e nella sua pratica clinica l’importanza del corpo, fatto, curiosamente, ignorato da molti.
Se Freud scopre la conversione isterica e la nozione di compiacenza somatica, Lacan, con la teoria del significante e il concetto di reale, introduce una nuova logistica che consente di cogliere meglio l’effetto del linguaggio sul corpo. La conversione isterica non implica un rimaneggiamento del corpo, né tracce di lesioni: questo salto dello psichico nell’organico resta, sul piano scientifico, un enigma. Nel fenomeno psicosomatico l’uomo di scienza riscontra modificazioni nell’organismo: resta incomprensibile il determinismo delle lesioni nei confronti dell’omeostasi del corpo. Ma l’implicazione di fattori genetici, immunologici e biochimici, specifici in questi processi, ravviva la curiosità poiché mostra implicitamente che il significante, anche nella sua espressione più semplice come il fonema, può avere un’azione sul genotipo umano, creando nella vita dell’individuo nuovi fenotipi.
Questi fenomeni interessano lo psicoanalista, perché essi implicano per il soggetto una specie di “fissazione” (Fixierung) particolare. “Bisogna sempre aver di mira – ricorda Lacan – che è per questo verso, cioè per la rivelazione del godimento specifico che egli ha nella fissazione che occorre affrontare lo psicosomatico”. Parte della medicina potrebbe ricevere nuove indicazioni dalla teoria del godimento secondo Lacan. Questa evidenza un po’ sorprendente allarga il campo del lavoro analitico, ma solleva anche numerosi problemi pratici, teorici ed etici nella direzione della cura.
Sottolineiamo l’espressione “godimento specifico”. Questa specificità comporta a mio avviso due aspetti: da un lato una certa modalità di godimento per il corpo, dall’altro l’apparire nella cura di una trascrizione particolare del fantasma del soggetto. Nel fenomeno psicosomatico il godimento è “autoerotico”. Si potrebbe supporre nella pulsione la mancanza di una distinzione tra la fonte e l’oggetto. C’è investimento sull’organo stesso. Tuttavia si potrebbe pensare questo godimento come un “organo supplementare”, come uno strumento (organo di fissazione) nel rapporto con l’Altro. Innesto immaginario che comporta lesioni che manifestano l’impossibilità di penetrare nel godimento del corpo dell’altro, fatto che è correlativo a effetti di “mimetismo”. Questo godimento rinvia a un sadismo originario o a un masochismo erogeno legato alla pulsione di morte e responsabile della reazione terapeutica negativa.
Nella cura si tratta di dare un “senso” al godimento connesso al fenomeno psicosomatico. Lacan sottolinea che “lo psicosomatico è, tutto sommato, nel suo fondamento, qualcosa di profondamente radicato nell’immaginario”. L’esperienza clinica dimostra che la sua remissione è collegata all’apparire di un fantasma inconscio. Il fenomeno psicosomatico sarebbe lo stigma dell’impossibile lavoro del fantasma. La chiave della cura risiede sovente in un sogno in cui un significante, isolato a livello dell’ombelico del sogno, è presente sotto forma di “olofrase”.
Il lavoro di ritaglio sull’olofrase, che ha generalmente una struttura trisillabica, introduce da una parte un triplice equivoco: un equivoco sul piano “omofonico”, che introduce una nota interrogativa a causa della diffrazione delle significazioni; un equivoco nel senso della “grammatica” in cui la parola-frase costituisce a partire da un verbo l’abbozzo di un fantasma non ancora riconosciuto dal soggetto; un equivoco sul piano “logico” in cui il ritaglio dell’olofrase rinvia a un conteggio, che rende presente il reale, con cui il fenomeno psicosomatico ha un’affinità.
D’altra parte, questo equivoco produce una sciamatura di significanti-principali (S1) che andranno a rappresentare il soggetto per altri significanti. In tale modo con un tale lavoro di ritaglio sull’olofrase si costituisce un “plusgodere”, isolando meglio la rimozione originaria. Una tale operazione ha come risultato non trascurabile l’emergenza di ricordi infantili che forse si possono collegare con lo stadio olofrastico di cui parla Jakobson, stadio che rinvia allo stadio dello specchio.
Ebbi occasione di cogliere l’importanza dell’olofrase nel discorso dei pazienti soprattutto nel 1975-1976, quando Lacan parlava di James Joyce nel suo seminario Il sinthomo. A partire da quel momento Lacan introduce una nuova concezione del corpo, articolata come un nodo borromeo a quattro, e cioè reale, simbolico, immaginario + il “sinthomo” specifico e inerente a ognuno.
Queste ricerche interessano gli analisti che lavorano con persone affette da fenomeni psicosomatici. Joyce stesso soffriva di reumatismi infiammatori (artrosi dorsale), di irite, di glaucoma, di cateratte che lo portarono, dopo l’operazione, alla quasi cecità. Morì del resto di un’ulcera gastro-duodenale perforata. Il “sinthomo” di Joyce, il suo Ego, si rivela nella sua scrittura, in particolare in Finnegans Wake, in cui l’artista sofferente crea “nomi propri” che risuonano come altrettanti ombelichi del sogno.
Nella pratica clinica ho notato che le olofrasi funzionano nel discorso dei pazienti come nomi propri o nomi di luogo, a contenuto translinguistico. Esistono omologie tra il discorso di questi pazienti e il discorso di Joyce. Lacan, studiando il problema della funzione paterna in Joyce, dà nuovi orientamenti sull’origine del fenomeno psicosomatico.
___
Poiché la versione cartacea di questo numero è esaurita, mettiamo a disposizione il PDF de La Psicoanalisi n.2 nel link del SOMMARIO dell'articolo. Per accedervi, è necessario effettuare la connessione e versare la quota come membro aderente dell'Atelier Tyto Alba ASBL.