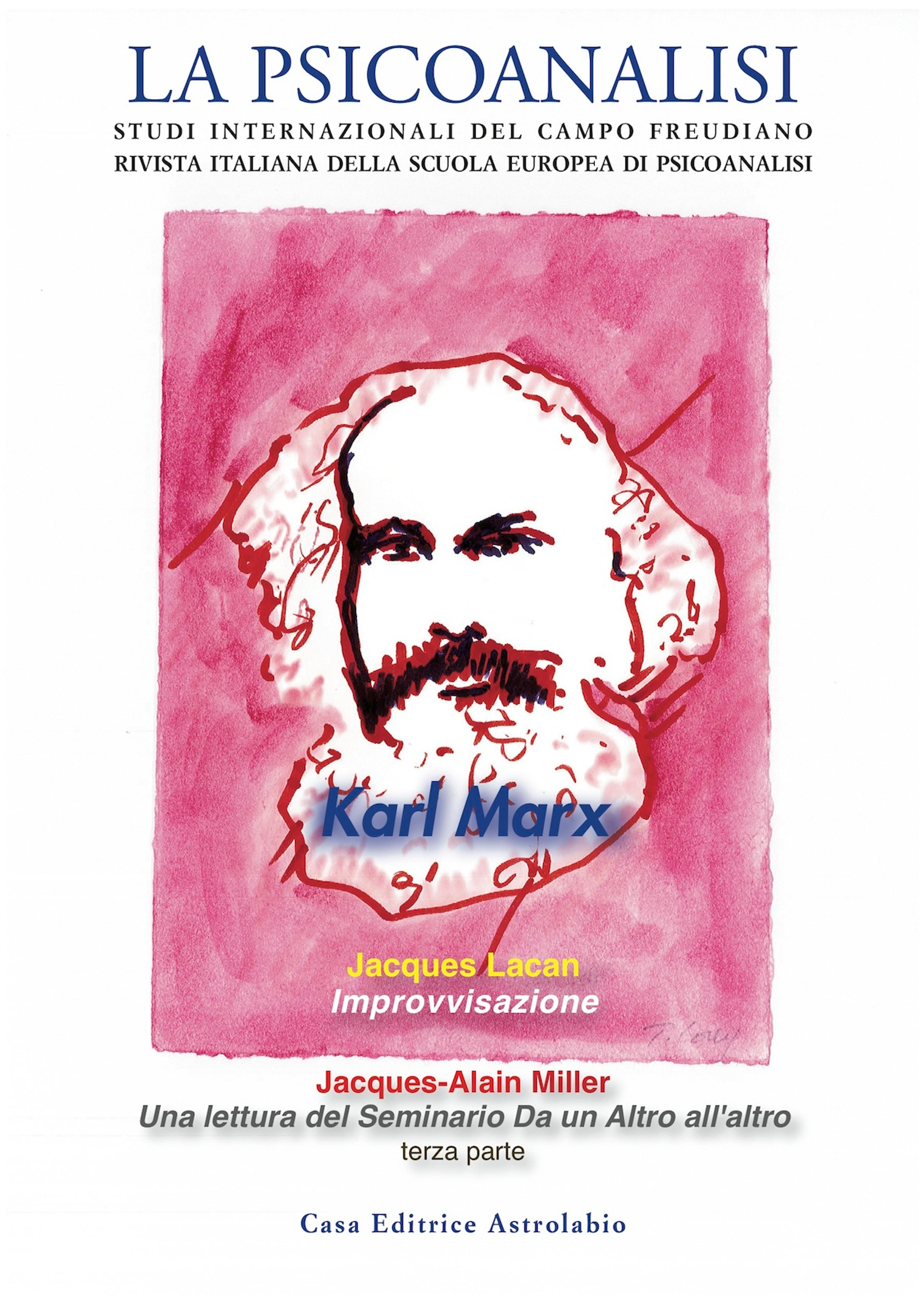“Mi appellerò a Marx, di cui mi è costato grande fatica – ne sono infatti contrariato da molto tempo – non introdurre prima il discorso in un campo dove nondimeno è perfettamente al suo posto. A partire da Marx procederò con un’estensione omologica per cominciare a stabilire oggi il posto in cui dobbiamo situare la funzione essenziale dell’oggetto a” (p. 11).
Così, fin dall’inizio del Seminario XVI, Da un Altro all’altro Lacan introduce Marx. In realtà è un autore che conosce fin dalla sua giovinezza. Studente in psichiatria, andando all’ospedale in metro, leggeva il Capitale. E il suo riferimento a Marx è presente fin dal suo Discorso sulla causalità psichica doveafferma che alcuni autori, come Socrate, Cartesio, Freud e Marx, non possono mai essere superati, a causa della loro passione per la verità (Scritti, p. 187).
Più volte nel suo insegnamento Lacan torna su Marx, a volte per criticarlo, come fa in Funzione campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi quando indica la differenza che separa “la ricerca storica autentica dalle pretese leggi della storia” (Scritti, p. 253) ponendo Marx in serie con il vescovo Bossuet e August Comte. Oppure, quando appoggiandosi su Lenin il quale aveva scritto che la teoria di Marx era onnipotente perché vera, Lacan si interroga, ne La scienza e la verità se la scienza economica ispirata al Capitale porti necessariamente a usarne come potere di rivoluzione, poiché una cosa è la verità come causa e un’altra cosa il potere messo in esercizio (Scritti, 873-4).
Critica che fa seguito a quella ben più articolata dell’Atto di fondazione: “Non è irrilevante che ci si possa meravigliare che il solo nome di Freud, con la speranza di verità che veicola, tenga testa al nome di Marx - sospetto mai dissipato, sebbene sia patente che l’abisso è incolmabile, che nella via dischiusa da Freud potrebbe scorgersi la ragione per cui il marxismo fallisce nel rendere conto di un potere sempre più smisurato e folle sul piano politico” (Altri scritti, p. 237). Qui Lacan distingue in Marx la teoria marxiana e la praxis marxista. La teoria marxiana va verso l’individuazione di elementi di struttura che sono quelli dell’inconscio. Al contrario, la praxis marxista non fa altro che sfociare in una serie di folli passaggi all’atto.
Tuttavia Marx è da Lacan indicato come il precursore dello stadio dello specchio o colui che era riuscito a mostrare il funzionamento tra un significante e l’altro come fa mettendo in rapporto la tela con il vestito o nel rapporto che stabilisce tra il valore d’uso e il valore di scambio. Rispondendo in francese alla Filosofia della miseria di Proudhon, nel suo Miseria della filosofia Marx, al dire di Lacan, riesce a mostrare come la valorizzazione dell’oggetto è al contempo la sua svalutazione, poiché se ne constata lo sradicamento dal campo del puro e semplice bisogno (Sem. VI, p. 122).
Sempre nel Seminario VI troviamo un riferimento marxiano maggiore poiché riguarda l’analisi del carattere feticistico della merce e del denaro.
Un altro punto fermo di Lacan, ripreso più volte, è l’aver attribuito a Karl Marx di essere l’inventore del sintomo, inteso nel senso psicoanalitico del termine. Dato che solo Marx ha individuato quella dimensione del sintomo non già come un errore ma come il ritorno della verità nella faglia di un sapere (Scritti, p. 227).
Il 18 marzo del 1980 in occasione dello scioglimento dell’École freudienne de Paris Lacan, all’improvviso, fece circolare un testo, inedito e importante, che viene subito dopo il testo sulla Dissoluzione, un discorso di tre pagine da cui traggo questo passaggio: “Ho reso omaggio a Marx in quanto è l’inventore del sintomo, eppure Marx è anche il restauratore dell’ordine per il solo fatto che ha dato nuova vita nel proletariato alla cosiddetta dimensione del senso. È bastato questo perché il proletariato egli possa chiamarlo così. La Chiesa se ne è servita, sappiate che il senso religioso nel futuro farà boom in un modo tale che voi non avete affatto idea di quanto questo boom sarà forte, per il semplice motivo che la religione è il luogo originario del senso. È un’evidenza che si impone. E coloro che nella gerarchia sono responsabili stiano, più degli altri, attenti. Io ho provato ad andare contro affinché la psicoanalisi non sia una religione, ma la psicoanalisi tende in modo irresistibile verso la religione, basta che la psicoanalisi si immagini che l’interpretazione operi tramite il senso. Io insegno che la sua spinta è altrove, per la precisione nel significante in quanto tale”.
Nel Seminario XVI qual è il punto centrale che Lacan trova in Marx? Direi che si tratta certamente di ciò che Jacques-Alain Miller dà come titolo alla prima lezione: “Dal plusvalore al plusgodere”. Ma si tratta anche delle conseguenze circa la posizione dello psicoanalista che è chiaramente espressa nel testo inedito di cui sopra.
In questo numero della rivista viene portato a termine il commento di Jacques-Alain Miller sul Seminario Da un Altro all’altro. Seguono due testi su Marx, uno di François Regnault e l’altro di Claudio D’Aurizio. In questo numero vengono riportati i lavori dei diversi gruppi di studio della Sezione clinica di Roma dello scorso anno accademico.
Thomas Corey, l’artista che già ci aveva fatto omaggio del profilo di James Joyce riprodotto in un numero precedente della rivista, ha voluto ripetere il suo gesto con questa copertina proponendoci la sua versione di Karl Marx.