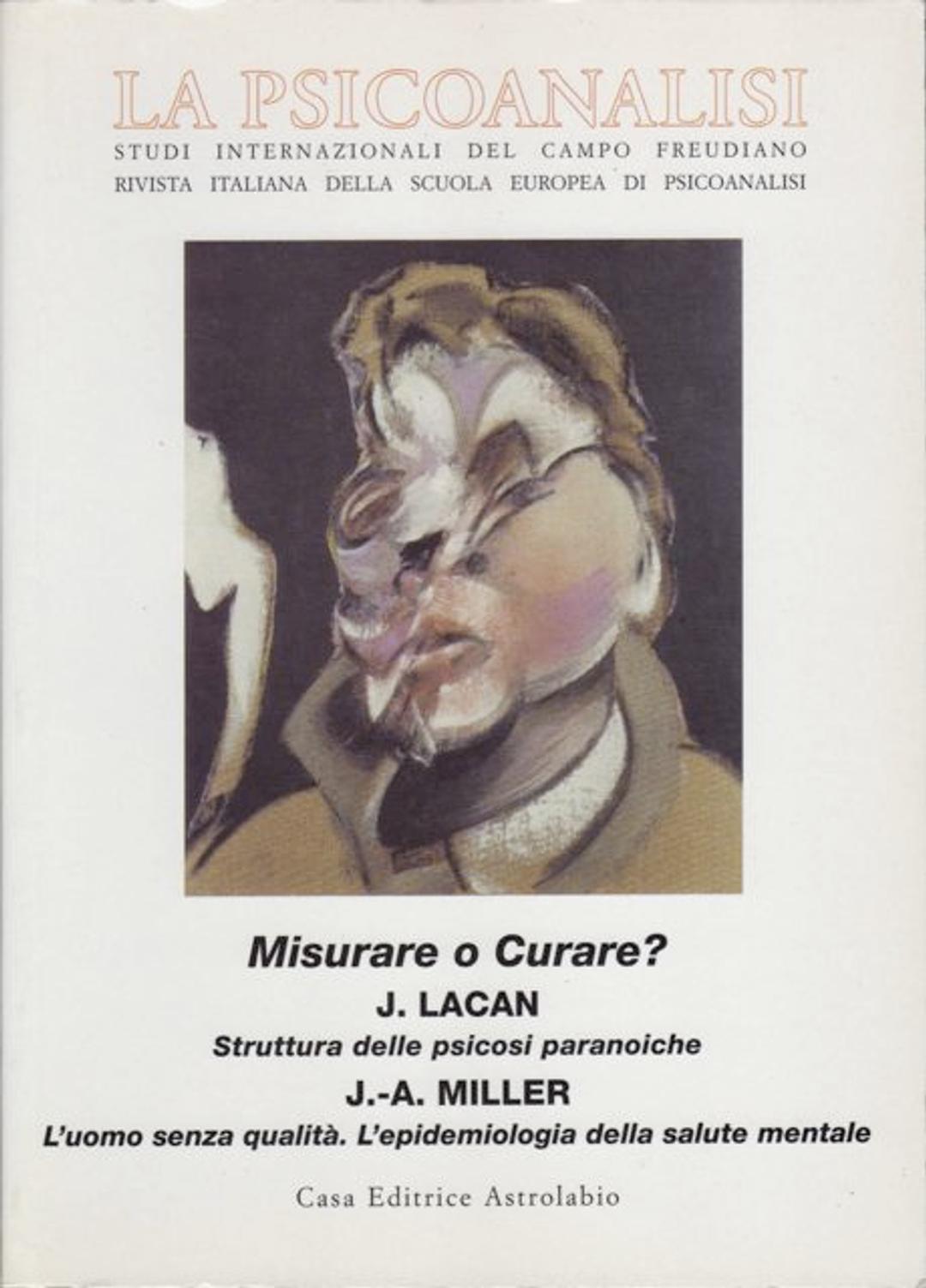Rispetto ai principi che erano alla base della cultura scientifica appena una cinquantina di anni fa, l’attuale cultura della tecnoscienza contemporanea si caratterizza per un notevole cambiamento di sensibilità e di impostazione. Non troviamo più, come allora, in primo piano l’imprevedibilità della ricerca creativa, con i propri oggetti e i propri tempi, bensì il pensiero che la scienza debba servire certi problemi, che il ricercatore deve confrontarsi con l’obbligo dei risultati, accompagnati da una valutazione ex ante ed ex post dagli stessi, il che tende a conferire alla ricerca un carattere sempre più strumentale e ci si occupa di seguire l’innovazione tecnologica piuttosto che lo sviluppo delle teorie scientifiche.
Nell’epoca in cui la scienza è produzione e trasformazione del reale non si può più scorporarne la dimensione psico-socio-politica dagli interessi particolari che essa mobilita, al punto tale che nel progetto Genoma Umano, un progetto simbolo della tecnoscienza attuale, almeno il cinque per cento delle risorse economiche sono state impiegate per lo studio delle implicazioni etiche, giuridiche e sociali del progetto stesso.
Alla tecnoscienza contemporanea corrisponde infatti un soggetto plurale e nient’affatto pacificato e ottimista bensì conflittuale, specialmente sull’ordine delle conseguenze innescate dai prodotti e dalle tecnologie della tecnoscienza che vanno, come si usa dire, anche sul mercato del consumo, e diventano per ciò stesso una questione che interessa chiunque.
Gli epistemologi quindi notano che il sociale entra sempre di più nei progetti scientifici e di ricerca e la domanda sociale li condiziona. Non a caso la valutazione dei risultati è così sempre più sostenuta dalle istituzioni e dalla politica, soprattutto per le ricadute che la valutazione ha sul piano dei finanziamenti.
Noi conosciamo molto bene ora questa cultura della valutazione che ha iniziato a espandersi e a voler imporsi anche al campo della psicoanalisi in nome dello scientismo contemporaneo. Di quest’ultimo si possono dare alcune definizioni, una è quella che lo scientismo è l’estensione “indebita” dei metodi della scienza a campi che non sopportano il passaggio al calcolo, alla misura, al mondo della quantità.
Ora, nella epoca della tecnoscienza, siamo, culturalmente parlando, costantemente dentro questa estensione o estrapolazione, siamo costantemente dentro, come dice Echeverria, l’ibridazione generalizzata tra scienza dura e scienze epistemologicamente deboli, le scienze umane, sociali ed economiche e quindi la frontiera tra scienze esatte e scienze dell’imprecisione sfuma, se ne perdono le tracce.
E’ quindi in questo terreno culturale che noi vediamo nascere e crescere il melange di idee che guidano una consistente fetta degli psicoanalisti IPA, quando cercano di coniugare il senso e la verità dell’inconscio freudiano con la causa posta al livello delle neuroscienze, oppure cercano di compiere una traduzione dei concetti freudiani nei termini del cognitivismo attuale, per trovarsi poi a condividere in un prossimo futuro le stesse aspettative dei cognitivisti nei confronti delle ricerche sperimentali che, al dire di questi ultimi, indagano le relazioni tra processi cerebrali e dinamiche interpersonali, in cui il monitoraggio del flusso ematico cerebrale può, a loro avviso, aprire spiragli nuovi agli studi dei processi cognitivi o l’uso della tomografia a emissione di protoni e la risonanza magnetica possono, li cito, “consentire di acquisire crescenti conoscenze riguardo alle relazioni esistenti tra aspetti psicologici, struttura cerebrale e metabolismo neurochimico” da cui poi ricavare validi ausili per la terapeutica.
Questo melange, questa ibridazione delle procedure tecniche, delle scienze e della soggettività in cui affonda questo scientismo, è esattamente il sottofondo culturale sul quale affonda le proprie radici l’ideologia della valutazione, che è parte intrinseca della teoria e della metodica cognitivo-comportamentale, ma è del tutto inapplicabile e ancor più fuorviante per quanto attiene alla psicoanalisi.
Quest’ultima, non a caso, è proprio l’oggetto di un attacco ideologico e rozzo fin dalle prime pagine del recente Trattato di terapia cognitivo comportamentale in cui si elencano subito i due scogli che si frappongono, in Italia, alla “conquista del mercato” psi da parte delle TCC (Terapie cognitivo-comportamentali).
Il primo scoglio sarebbe il pregiudizio ideologico nei confronti di una psicoterapia, la TCC appunto, che è considerata figlia del capitalismo anglosassone. Il secondo scoglio “più vischioso e pernicioso” soprattutto per l’impatto culturale, è la psicoanalisi, che continua a godere “nel nostro paese”, dicono i curatori, di una fiducia notevolissima, quasi inossidabile da non poter essere facilmente intaccata da prove scientifiche.L’appello alle prove scientifiche e al criterio della valutazione rappresenta quindi l’angolatura principale entro cui, per l’ennesima volta, si ripete il principio secondo il quale la psicoanalisi non è una scienza, non è valutabile con i criteri quantitativi e di misurazione dello scientismo contemporaneo.
Infatti è esattamente così, la psicoanalisi non è una scienza: è una pratica clinica che è applicata a un reale del tutto diverso da quello della scienza e quanto mai da quello del melange scientista a cui spesso fanno riferimento i valutatori infatuati dalla TCC. Il reale della psicoanalisi è, come lo definisce Lacan, il sintomo, cioè “il reale al nostro livello di esseri parlanti”, il livello in cui la soggettività è segnata dal fatto che non si trova equazione matematica possibile con la quale scrivere la legge del rapporto tra i sessi, per utilizzare un’espressione di Lacan. La nostra, a differenza degli ideologi delle TCC, è una soggettività che si confronta con questo reale di cui non è possibile fornire la legge, e al posto di questa legge scientifica mancante c’è il sintomo, la forma della soggettività umana intrattabile dai calcoli, dalle misurazioni e dalle norme del tecnoscientismo contemporaneo.