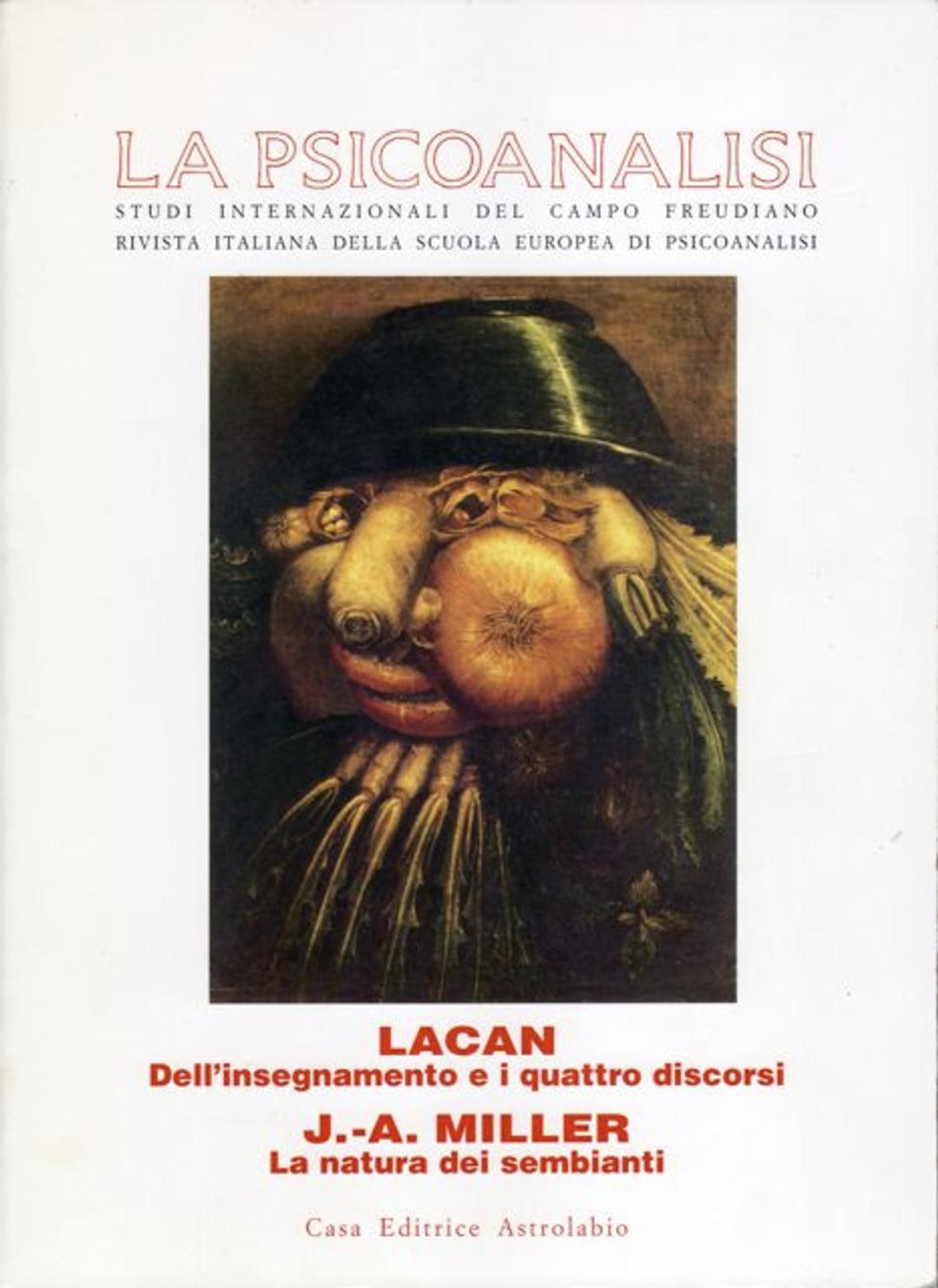Lacan introduce “i quattro discorsi” nel suo Seminario del 1969- 1970 L’envers de la psychanalyse, Il rovescio della psicoanalisi.
Questi quattro discorsi affondano le loro radici in Freud stesso. Freud ricorda aver fatto suo sin dai primi tempi un vecchio adagio delle tre professioni impossibili: governare, educare e curare, Regieren, Erziehen, Kurieren. L’analisi è l’ultima arrivata e, nota Lacan, “Freud la mette nella serie per sostituzione. Le tre professioni, ammesso che si possa parlare di professioni, sono quindi Regieren, Erziehen, Analysieren, vale a dire governare, educare e analizzare. Non si può non notare la sovrapposizione di questi tre termini con quel che io preciso quest’ anno come ciò che costituisce il radicale di quattro discorsi” (Sem. XVII, p. 193-4).
In questo numero de La Psicoanalisi, oltre ad altri lavori, troviamo, nella prima parte, testi di alcuni Colleghi che inquadrano i quattro discorsi nell’insegnamento di Jacques Lacan e ne mettono a fuoco la funzione e l’operatività.
Proprio per illustrare questa funzione e operatività abbiamo qui riportato il discorso conclusivo pronunciato da Lacan il 19 aprile 1970 in occasione del congresso dell’Ecole freudienne de Paris intitolato Dell’insegnamento.
Lacan sembra meravigliato del fatto che nessuno tra i relatori del congresso abbia fatto uso e consumo delle “mie piccole forme a quattro zampe” sviluppate nel suo insegnamento dell’anno in corso. Meraviglia relativa, per la verità, abituato com’egli era al fatto che “ci si metta dieci anni a fare uso delle cose che [...] non posso dire di non lasciare in giro alla portata di tutti. Così c’è gente che ha saputo approfittarne molto bene, esportandole per un uso diverso. Del resto non ci vedo alcun ostacolo”, conclude.
Tuttavia, per quanto riguarda l’insegnamento, l’utilizzazione dei quattro discorsi andava proprio a pennello, e avrebbe evitato ai relatori di incorrere in “certi scivolamenti”.
Lacan tratteggia nel suo intervento una certa linea. Linea che, come avviene in un discorso parlato, è percorsa da incisi, parentesi e notazioni a volte veramente gustosi. Si veda ad esempio la definizione della noia che preannuncia quella di Télévision; l’appunto fatto al Partito (Comunista), luogo d’elezione dei valori borghesi; oppure il ricorso al Padreterno per raffigurare l’operazione del significante sul godimento; o ancora la notazione sull’utilizzo improprio di concetti filosofici nel campo analitico, come sono i concetti-quesito e i concetti-risposta, dato che, ricorda Lacan, nella psicoanalisi la risposta è già presente prima del quesito.
Anche nella sua linea tratteggiata circa l’insegnamento Lacan non manca di humour. “Questo Congresso è un insegnamento”, questo Congresso” mi ha insegnato molto”. Ma se Lacan si mette al posto dell’insegnato, non è per questo che individua nei relatori i suoi insegnanti. Si può essere insegnati, “non necessariamente per via di un insegnamento”, ma “attraverso un sacco di cose, attraverso un gesto, attraverso un atto, attraverso più di una categoria”. E così ci rivela che laddove è stato insegnato, lo è stato circa la coniugazione effettuata dai relatori tra la funzione dell’insegnamento con il sapere. Quando invece, ricorda, anche l’ultimo dei pedadoghi sa che tutto sommato la funzione dell’insegnamento è forse, al contrario, proprio quella di “barrare il sapere”. “Sapere che c’è già, rigoglioso, prima ancora che qualcosa si instauri - istituendosi come insegnamento”.
Ecco dunque da una parte messa in questione la cosiddetta relazione insegnante-insegnato, la quale, come dovrebbe essere chiaro nella coppia amante-amato, rivela che, se esistono azioni che si trasmettono, i verbi invece sono sempre e solo intransitivi. I verbi, eventualmente, possono essere reciproci, ma non transitivi. L’amante, per esempio, “lo dico reciproco perché suscita sempre dell’amante, ma necessariamente di rimando”. Insomma, la coppia di termini insegnante-insegnato merita una sovversione simile a quella operata nella coppia di termini analizzante-analizzato, dove non si tratta, ricorda, che “io abbia solo rovesciato lo psicoanalizzato come la pelle di un coniglio”.
D’altro canto, per far uscire dall’opacità i rapporti tra insegnamento e sapere, per poterli chiarificare, bisogna ricorrere a strumenti adeguati. Cosa che sarebbe stata a portata di mano “se qualcuno avesse fatto uso dei miei piccoli schemi di quest’anno”. E riprendendo i suoi schemi Lacan nota che l’insegnante può esservi solo laddove c’è S barrato. Per questo in un’analisi l’insegnante non è l’analista, ma l’analizzante. “Il che è del tutto indipendente dal fatto che per l’insegnante, all’occasione l’analizzante, il proprio sapere è inconscio, vale a dire a nessun livello a sua disposizione, anche se è un sapere in posizione di verità”.
Ma “la vera questione”, sottolinea Lacan, “è quella di sapere se nel discorso analitico il sapere giochi per l’analista lo stesso ruolo di copertura, di maschera, di occultamento del posto della verità”. Ad ogni modo è ancora l’S barrato “l’unico punto in cui, nel discorso analitico, l’analista può sperare di accedere alla funzione dell’insegnante”. Rimane sì analista, ma in quanto insegnante l’analista “si trova nella posizione dello psicoanalizzante, offerto come tale nella posizione dell’Altro”, posizione che, “per definizione, non è affatto dominabile, in altri termini [...] dove si possa manifestare una qualsiasi cosa dell’ordine della padronanza”.
Terminiamo, con questo numero, la pubblicazione del Corso di Jacques-Alain Miller, tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’anno accademico 1991-92, La natura dei sembianti.