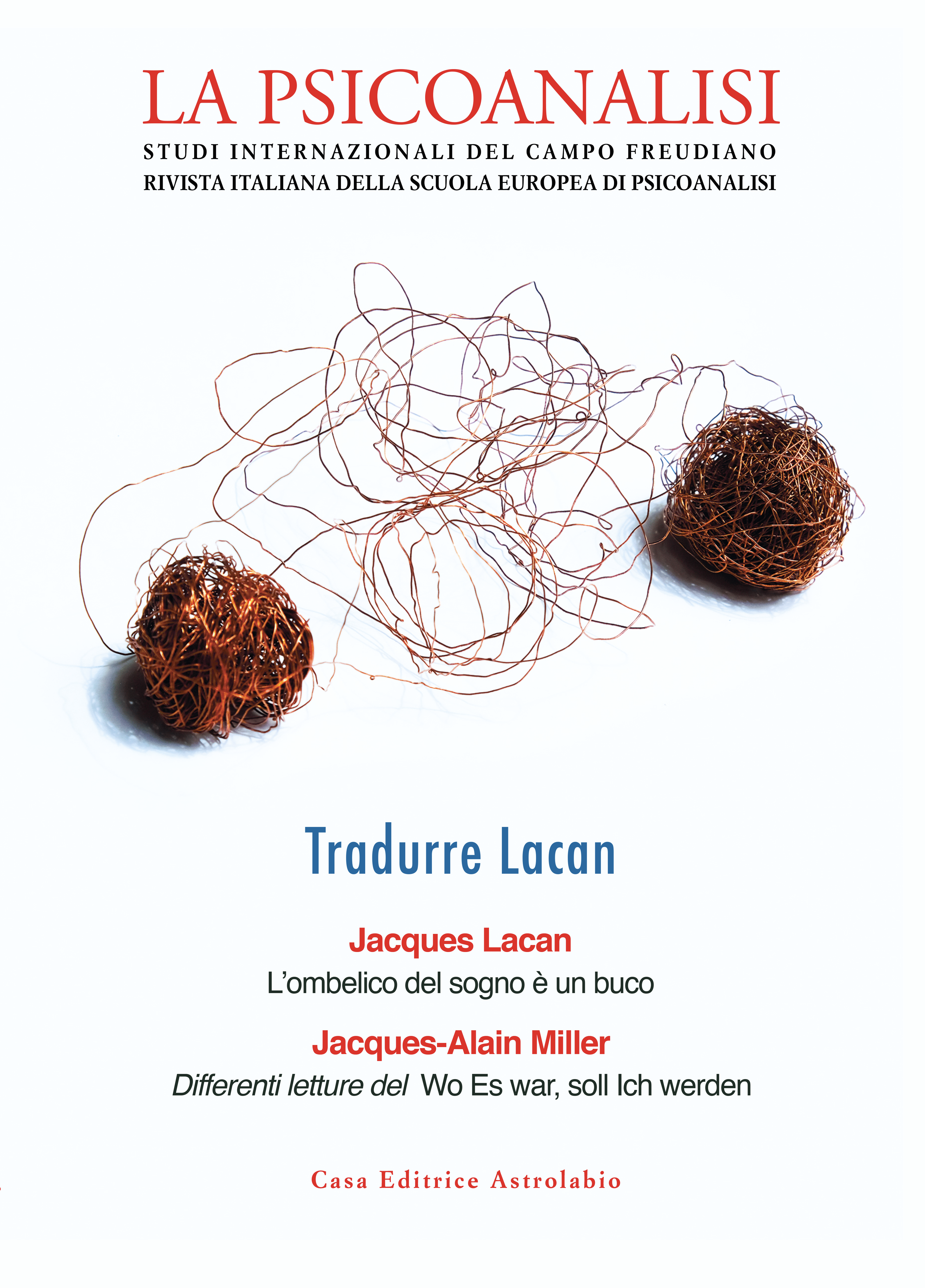Nell’Unerkannte, articolato da Freud con la questione dell’ombelico del sogno, si può identificare il reale? Si potrebbe trattare forse del reale pulsionale? E se così fosse, seguendo Freud che mette in tensione l’ombelico del sogno con il desiderio, quale rapporto intercorrerebbe fra questo reale e il desiderio?
Strasburgo, 26 febbraio 1975, è lo psichiatra e psicoanalista Marcel Ritter a porre a Jacques Lacan questi interrogativi. La risposta improvvisata da Lacan è prolissa – come egli stesso afferma – e originale, tanto che verrà pubblicata nel 1976 in Les Lettres de l’EFP e poi riproposta ne La Cause du désir nel 2019. 1 È un picchetto del punto dell’insegnamento in cui egli si trova, a cui è giusto fino a quel momento; non è dunque un riassunto delle argomentazioni percorse nel tempo, né una parola conclusiva che chiude la questione, anzi, porta l’attenzione su inaspettate sfaccettature da interrogare. Si ha la possibilità, in questa manciata di pagine, di seguire Lacan nel working progress della sua risposta, nelle ferrate ripide della messa in opera di un avanzamento costante e a volte vorticoso – così come, del resto, avviene nei Seminari. “Dunque do la mia risposta attuale. È tutto quello che posso dire: sono arrivato a questo punto” inizia Lacan “non penso sia il reale pulsionale. È difficile da fare capire. Non posso tracciare di nuovo tutta la strada che ho percorso per arrivare a questo punto. Mi meraviglierebbe molto se qualcosa mi spingesse a un’altra concezione”. 2 Lacan accosta invece l’Unerkannte all’Urverdrängt, dunque il ‘non-riconosciu to’ con il ‘rimosso primordiale’, che non può essere detto in quanto è alla radice stessa del linguaggio. L’ombelico è lo stigma, cicatrice di un’origine. Il reale pulsionale se ne distingue, si può parlare di un’analogia sottolinea Lacan, ma non sono esattamente la stessa cosa. Il lettore potrà appassionarsi ai tornanti attraverso cui Lacan darà spessore a questa distinzione. In questo tragitto Lacan ribadirà anche qualcosa sul desiderio, e lo fa senza mezzi termini quando afferma: “il desiderio dell’uomo è l’inferno [...] e lo dico per la prima volta qua davanti a voi oggi”. Una bussola, per i lettori a venire, che orienta nello scansare il rischio di scivolare in letture del desiderio che ammiccano alla pacificazione, a una riconquista romantica di qualcosa di nostalgico. Non è di questo che si tratta quando si parla di desiderio, si sa, e Lacan non esita a rimarcarlo chiaramente.
Il testo di Jacques-Alain Miller scelto per questo numero – breve e incisivo estratto dei Capisaldi dell’insegnamento di Lacan – punteggia lo spostamento dello statuto del soggetto nella doppia riscrittura operata da Lacan del desiderio freudiano, attraverso due delle differenti letture, fatte da Lacan nel tempo, del Wo Es war, soll Ich werden di Freud. Più nello specifico Miller mette a confronto la lettura del 1955 presente ne La Cosa freudiana con il commento successivo di Sovversione del soggetto “per verificare lo scarto di cui si tratta nella concezione di Lacan”. Il brano apre la strada al tema che costituisce il cuore di questo numero: la traduzione. Sarà lo scritto introduttivo di Francesco Paolo Alexandre Madonia ad accompagnare il lettore passo passo nella pulsante e variegata sezione “Tradurre Lacan” che si apre con il testo “Lacan e il problema della traduzione” pronunciato da Antonio Di Ciaccia all’Università degli studi di Palermo il 24 aprile 2024.
Procediamo poi, come di consueto, con l’Orientation lacanienne di Jacques-Alain Miller. In questo numero compaiono altri tre capitoli di 1, 2, 3, 4, la cui pubblicazione è iniziata nel numero precedente della rivista. Si tratta del corso tenuto da Jacques-Alain Miller nell’anno accademico 1984-1985, incentrato sul Seminario XIV di Jacques Lacan La logica del fantasma, da poco pubblicato anche in italiano per la casa editrice Einaudi.