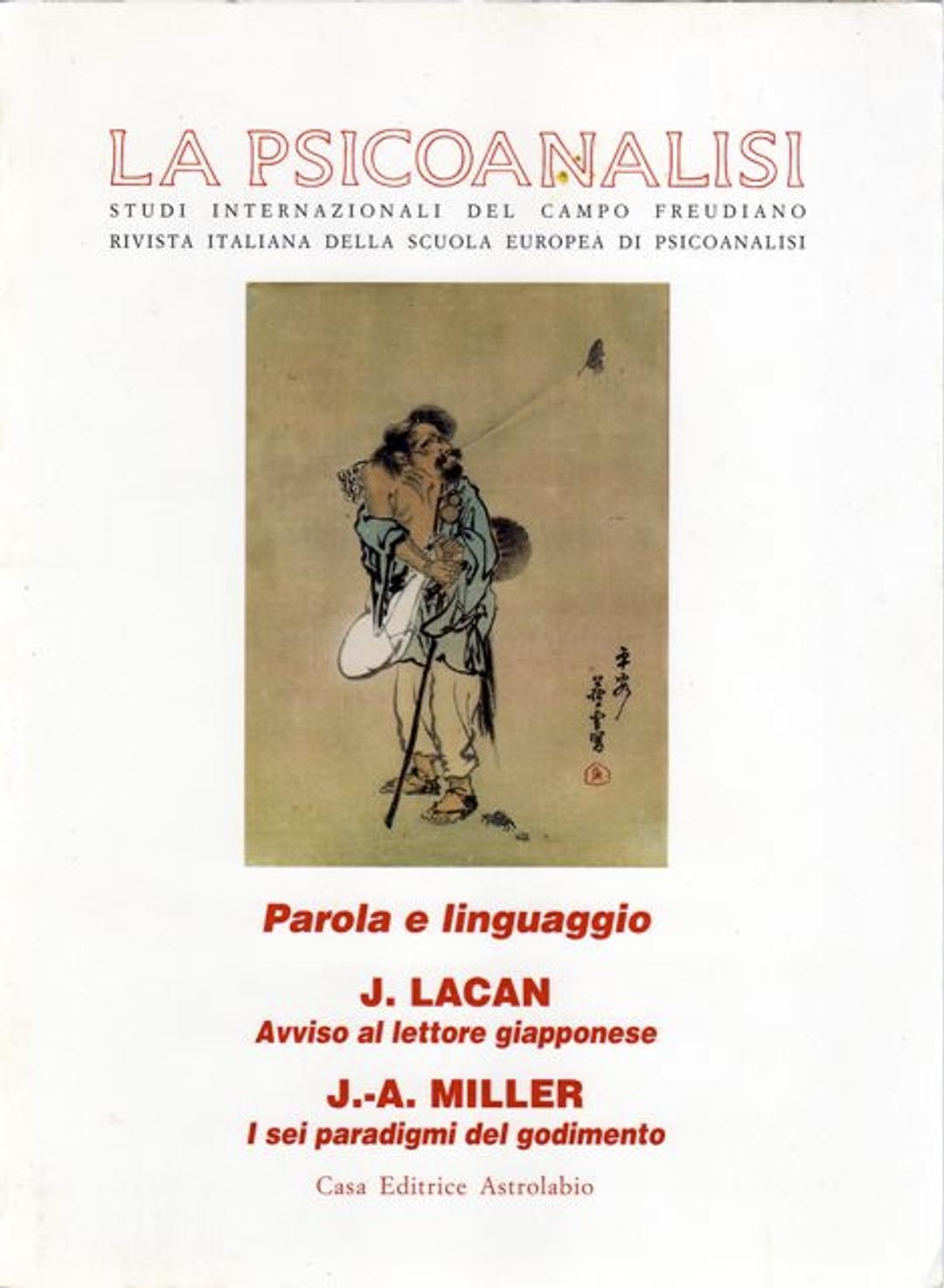Lacan perplesso di fronte alla traduzione giapponese dei suoi Scritti. Sicuramente altrettanto perplesso quanto un Giapponese che cercherà di leggerli! Ma se la perplessità è la stessa, i motivi sono del tutto diversi.
Il Giapponese infatti non vi troverà, nella traduzione degli Scritti, se non un testo che traduce un discorso in un altro discorso. Voglio dire: non solo tradotto da una lingua in un'altra, dal francese in giapponese (cosa che deve essere di una difficoltà spaventosa), ma tradotto dal discorso analitico in un altro discorso. In questo caso il traduttore-traditore snatura, volens nolens, il discorso analitico stesso, come fece notare Lacan a pagina 43 del Seminario XVII Il rovescio della psicoanalisi (Einaudi)a proposito della "traduzione" effettuata da Serge Leclaire di un'espressione chiave dell'insegnamento di Lacan, tradotta dal discorso analitico nel discorso universitario, e quindi tradito.
Il discorso analitico sarà quindi, per un eventuale lettore giapponese, improntato come un discorso universitario oppure come una comunicazione di tipo scientifico o ancora come un discorso che tratti dei significanti di un Maître lontano, astruso più che mai. Il lettore giapponese non vi troverà, dunque, ciò che costituisce e struttura il discorso dell'Analista.
La perplessità di Lacan ha, invece, origine diversa. Essa si situa nel fatto che, pur essendo il discorso giapponese un discorso altro rispetto ai tre citati - il discorso del Maitre, il discorso dell'Università e il discorso dell'Isterica -, non è tuttavia il discorso dell'Analista. Anzi, sebbene da una parte il discorso giapponese fa il verso al discorso analitico, dall'altra se ne discosta ampiamente.
L'uno come l'altro, infatti, sono discorsi fatti di segni che vestono il "niente". Non a caso Lacan fa riferimento a "quell'Impero dei segni con cui Barthes ci ha deliziato" e che egli traduce nell'espressione Impero dei sembianti. Nel senso, come ricorda Jacques-Alain Miller nel suo articolo pubblicato in Lacan et la chose japonaise(Navarin), che il discorso giapponese mette a nudo la struttura di finzione della verità, Io statuto di sembiante del significante e la vacuità del soggetto. Eppure parlare dell'Impero dei sembianti non è sufficiente poiché, a mantenere il parallelismo tra i due discorsi, quel che importa sarebbe il fatto di delineare in che modo il godimento giapponese trovi posto, si articoli e sia prodotto a partire dall'Impero dei sembianti.
Il discorso giapponese è inoltre simile al discorso dell'analista poiché rifugge dall'universale: sembra che in Giappone non ci si possa rivolgere a uno qualunque parlandogli una lingua comune, poiché si dovranno utilizzare segni particolari per ogni soggetto, indirizzandogli solo i segni a lui appropriati. Nel nostro mondo occidentale - o piuttosto "occidentato", come lo chiama Lacan - tranne per qualche eccezione che conferma la regola, tutto viene smussato in un discorso comune valido per tutti e per ognuno. Forse fu Carlo V a iniziare il livellamento dell'interlocutore del soggetto lanciando il suo Todos caballeros dagli spalti della fortezza di Alghero. Questo porta il mondo giapponese a una sorta di snobismo di punta - "snobelismo", lo chiama Lacan - che indulge in un "legame sociale molto raffinato". Eppure anche qui risalta in modo netto la diversità tra i due discorsi poiché, se l'interlocuzione è sempre particolare, non si comprende bene in che modo, in Giappone, possa essere incarnato il valore universale dell'Altro della parola.
Sempre sul parallelismo tra discorso giapponese e discorso dell'Analista si potrebbe aggiungere la scomparsa del soggetto e dell'Altro. Ma anche qui le similitudini coprono una profonda divergenza: la barra portata sull'Altro ha, nei due discorsi, struttura diversa: la barra portata sull'Altro inteso come luogo della parola nel discorso giapponese non è la stessa che segnala che l'Altro del linguaggio non è garantito fondamentalmente dall'Altro della legge.
Parallelamente, mentre il soggetto è destituito nel discorso analitico, è invece polverizzato nel discorso giapponese, tanto che si potrebbe dire essere messo in questione quel tratto unarìo che è il significante di base suscettibile di colmare la mancanza fondamentale del soggetto. La polverizzazione del soggetto si accompagna dunque alla nebulizzazione dell'Altro.
Abbiamo poi un'altra somiglianza tra il discorso giapponese e il discorso analitico: esso consiste nell'accentuazione della lettera a scapito del significante. Il discorso dell'Analista, tramite il significante, delinea i contorni del godimento, designato con la lettera a. Il discorso giapponese dà una consistenza speciale allo scritto: è una lingua che, per eccellenza, è sostanzialmente intaccata dalla lettera o, meglio, intaccata da quei tratti di scrittura che prendono la forma della calligrafia.
Ora, se la calligrafia, in Occidente, non arriva mai a cogliere, con un solo tratto di scrittura, il godimento fondamentalmente perduto, in Giappone, la calligrafia è la modalità che utilizza il discorso giapponese come tentativo per recuperare il godimento. E lo fa essendo una sorta di coalescenza tra il tratto, che è dell'ordine significante, e l'oggetto a, che è il prodotto, litura.
Il che comporta che il Giapponese è il soggetto che, piùdi chiunque altro, si appoggia sullo scritto. Certo, anche nelle lingue occidentali, il rapporto allo scritto si distingue dalla parola, seppur in modi diversi, lingua per lingua.
Ma nella lingua giapponese c'è una diversità tra la parola che serve a dire e la parola che serve a leggere lo scritto. E sebbene da questa diversità il Giapponese sia diviso, egli ci si ritrova tuttavia a suo agio poiché uno dei suoi registri si soddisfa con la parola, mentre l'altro si soddisfa con il riferimento alla scrittura. E mentre l'occidentale, come nota Jacques-Alain Miller, si soddisfa da una parte nel registro della parola e dall'altra nel registro del fantasma, per il Giapponese, al posto del fantasma, il soddisfacimento si ottiene per via della scrittura presa come oggetto. Forse è questo il motivo per cui, mi sembra, non c'è letteratura capace di insegnare che cos'è la perversione in modo così pertinente e affascinante come la letteratura giapponese.
Questa concrezione nella scrittura è quello che fa dire a Lacan che il Giapponese offre l'esempio di un soggetto chiuso all'inconscio. E gli fa dire che in Giappone la sola posizione possibile per un analista potrebbe essere quella di incarnare una calligrafia.
Così termina del resto Lacan il suo Avviso al lettore Giapponese :al posto dell'analista, in Giappone ci vorrebbe unicamente "uno stilo". Mentre a Lacan, per tenerne la funzione, gli serve unicamente "uno stile" (Altri scritti, Einaudi, p.497).